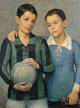Carlo
Socrate
Mezzana Bigli, Pavia, 1889 - Roma, 1967
All’età di nove anni si trasferisce in Argentina con i
genitori. A Rosario di Santa Fé il giovane artista dipinge i
fondali del teatro, spinto dal padre Bonaventura, che a sua volta aveva
affrescato la chiesa parrocchiale di Mezzana Bigli. Ottenuta una borsa
di studio, lascia l’Argentina e torna in Italia per dedicarsi
alla pittura. Si trasferisce a Firenze (1911-1913), dove è allievo
di Giovanni Costetti e compagno di corso di Ercole Drei. Partecipa all’Esposizione
Internazionale di pittura, scultura, architettura e bianco e nero alla
Società delle Belle Arti di Firenze nel 1913 e, l’anno
seguente, si trasferisce a Roma. Alla trattoria Fiorelli, punto di ritrovo
del mondo artistico romano, conosce Zanelli, Carena, Pieretto Bianco,
Scopinich, Tozzi, Ferrazzi e Spadini.
Comincia a dipingere nello studio che divide con Brunati e contemporaneamente
frequenta le lezioni della Scuola libera del nudo; si lega d’intensa
amicizia ad Armando Spadini e alla sua famiglia. La guerra chiama alle
armi Oppo, Carena, Spadini e Brunati; Socrate si arruola volontario
tra i Lancieri di Firenze. E’ in mostra, tuttavia, a Buenos Aires
(1915) e insieme al gruppo romano partecipa alla IV Esposizione Internazionale
d’Arte della Secessione a Roma (1916).
Nel 1917 l’artista è nella Compagnia dei Balletti Russi
di Diaghilev, insieme a Depero. Cura la scenografia ed esegue i costumi
per Las Meninas, in scena al Teatro Costanzi di Roma. Nello stesso anno
a Parigi conosce Picasso che elaborava allora i fondamenti teorico-stilistici
del suo periodo neo-classico. Ne diventa amico ed insieme eseguono l’apparato
scenografico per il balletto Parade. Socrate segue Pablo Picasso nei
suoi spostamenti in Spagna (Madrid e Barcellona), facendo tesoro delle
sue lezioni sulla potenza pittorica di Velasquez e Rubens. Gli effetti
dell’incontro con Picasso sono evidenti nelle opere esposte nel
1918 alla Casina del Pincio a Roma, di sapore totalmente nuovo per l’ambiente
romano, anche se si scorgono ancora stilemi spadiniani. Trasferisce
il suo studio a Villa Strohl-Fern. Espone alla Mostra d’arte indipendente
alla Galleria dell’Epoca e presenta, alla Mostra d’arte
giovanile alla Casina del Pincio, disegni e nature morte che riscuotono
il consenso della critica. Partecipa con il Gruppo Romano alla Famiglia
Artistica di Milano (1920); le opere esposte, recensite da un ironico
De Chirico, sono Ritratto della pittrice, Nature morte e Paesaggi. Partecipa
a varie collettive alla Casa d’Arte Bragaglia di Roma; nel 1920
presenta Ritratto di Vittoria Morelli e Interno, opere emblematiche
di una nuova tendenza della pittura, volta al “ritorno”
all’arte degli antichi maestri. Sempre nel 1920 partecipa I Biennale
romana; sarà presente anche alla II (1923-1924) e alla III (1925)
edizione e alle Quadriennali della città (1931, 1935, 1939).
Carlo Socrate, dopo aver condiviso il linguaggio avanguardista della
Scuola Romana, in particolare di Spadini, se ne allontana per dedicarsi
ad una ricerca di più rigorosa impostazione formale, che sviluppa
nell'ambito del gruppo di Valori Plastici (1918-1922), con cui espone
a La Fiorentina Primaverile di Firenze nel 1922, presentato da Alberto
Savinio. Partecipa alle Quadriennali di Torino (1923, 1927), all’Esposizione
di venti artisti italiani alla Galleria Pesaro di Milano (1924-1925)
- una mostra che intende documentare la molteplicità delle forme
espressive nella cultura artistica italiana del tempo - e alla I Mostra
del Novecento Italiano alla Permanente di Milano (1926). A Roma espone
alla Mostra degli Amatori e Cultori di Belle Arti (1927), alla Nazionale
d’Arte Marinara (1928) e a varie mostre Sindacali. Gli anni Trenta
vedono il pittore impegnato all’estero: espone Le bagnanti e Danae
a Pittsburg e a Baltimora (1931-1932) e partecipa alla mostra collettiva
d’Arte Italiana di Parigi (1935). E’ presente alla XXI (1938)
e alla XXVI (1952) Biennale di Venezia. In vista dell’E 42 elabora
un ciclo di affreschi per la decorazione della cupola del battistero
della chiesa romana dei SS. Pietro e Paolo. Nel 1945 partecipa alla
collettiva alla Galleria La Gregoriana di Roma.
Lascia l’insegnamento presso il Liceo Artistico di Roma e riceve,
nel 1966, la nomina a membro dell’Accademia di San Luca.
S.P.
13 - Piccoli
calciatori, 1929
Olio su tela, cm 85,3x70,3
Collezione privata
|
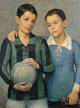 |
Esposizioni
Mostra del Novecento Italiano, Buenos Aires, 1930; II Quadriennale Nazionale
d’Arte, Roma, 1935; Scuola Romana: pittori tra le due guerre, Galleria
Cembalo Borghese, Roma, 1983; Carlo Socrate, Palazzo Venezia, Roma, 1988.
Bibliografia
Mostra del Novecento Italiano, cat. mostra, Buenos Aires, 1930, n. 174,
p. 37; II Quadriennale Nazionale d’Arte, Roma, 1935, n. 7, p. 150;
La II Quadriennale romana, in “Gazzetta del Popolo”, Roma,
26 gen. 1935; U. Ojetti, Attraverso le sessantadue sale della mostra,
in “Corriere della Sera”, 5 feb. 1935; M. Biancale, La pittura
alla II Quadriennale nazionale, in “Il Popolo di Roma”, 16
feb. 1935; F. Callari, II Quadriennale d’Arte Nazionale, in “Conquiste”,
Roma, 1935, pp. 94-95; Carlo Socrate, in Enciclopedia Italiana, XXXI,
Roma, 1936, p. 1026; Scuola Romana: pittori tra le due guerre, cat. mostra,
Roma, 1983, p. 153; M. Quesada (a cura di), Carlo Socrate, cat. mostra,
Roma, 1988, n. 51, ripr. p. 81, p. 222.
|